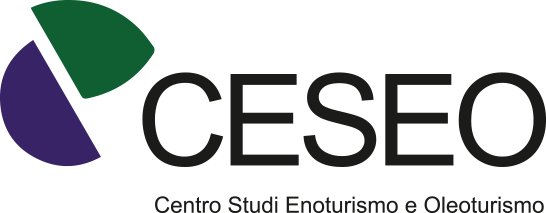ALL’ESTERNO DELLA CANTINA TURISTICA
Di Donatella Cinelli Colombini direttore Ceseo
Il percorso verso la cantina è insieme un problema e un’opportunità. Ovviamente le imprese che si trovano lungo una strada di transito turistico, e ancor meglio di traffico enoturistico, sono avvantaggiate.
Dall’indagine Nomisma -WineMonitor 2023 risultava che il 44% delle cantine aperte al pubblico sono lontane dalle aree interessate al turismo e solo il 32% hanno flussi enoturistici in prossimità.
Ma chi vuole ricevere visitatori deve comunque riuscire a farsi vedere almeno dalla più vicina strada di grande passaggio. E’ difficile, perché le frecce direzionali possono essere installate solo nei due incroci più vicini all’azienda, ma vale la pena acquistare delle insegne e cercare di indirizzare i flussi nella propria direzione.
FRECCE STRADALI
Non è importante come in passato, perché quasi tutti i turisti cercano le cantine da visitare, usando i navigatori o le App degli smartphone, ma comunque un’insegna ben fatta può essere molto utile.
La procedura autorizzativa per le frecce segnaletiche è lunga e vale la pena iniziarla con grande anticipo. La concessione viene rilasciata dall’ente titolare della strada cioè da Comune, oppure Provincia o ANAS. Il cartello deve riportare sul retro il numero dell’autorizzazione. A seconda del tipo di strada le frecce hanno dimensioni diverse. La posizione del cartello va concordata con l’ente gestore della strada. Quindi, per non sbagliare, è meglio rivolgersi a ditte esperte.
Purtroppo non esiste un simbolo stradale per le cantine turistiche mentre le aziende ne avrebbero bisogno per attrarre i visitatori. Infatti la maggior parte degli enoturisti arriva in zona con un solo appuntamento e poi fissa le altre esperienze last minute. Sarebbe importante spingerli a una visita anche usando la segnaletica stradale.
CARTELLONI PUBBLICITARI
Per le frecce direzionali le cantine pagano annualmente la tassa di suolo pubblico mentre per le insegne pubblicitarie c’è una doppia imposizione anch’essa annuale.
I cartelloni sono generalmente gestiti da ditte specializzate e hanno grossi limiti alla loro installazione. Prima di mettere qualunque cartello è necessario rivolgersi all’ente titolare della strada.
Qualche consiglio per i pannelli pubblicitari: limitare le scritte, usare solo caratteri in stampatello e non colorare il fondo di scuro. Ho fatto questo errore e vi assicuro che, di notte, i miei cartelli risultano invisibili.
LA GEOREFERENZIAZIONE
Ovviamente la visibilità online delle cantine turistiche è determinante. La georeferenziazione è quasi esclusivamente quella di Google Maps. Per questa ragione il profilo dell’azienda va curato con il massimo impegno aggiornandolo periodicamente perché contiene anche foto e informazioni come, ad esempio, l’orario di apertura al pubblico.
LA STRADA DI ACCESSO
Le condizioni della strada di accesso sono importanti: la lunghezza dello sterrato, le buche, le curve a gomito, i guadi e persino i rami degli alberi che graffiano il tetto dei bus, possono dissuadere i visitatori e soprattutto le agenzie.
Rimuovere gli ostacoli, quando è possibile, ha un carattere prioritario.
L’esterno della cantina turistica è importante più di quanto non si creda: crea un’aspettativa nei visitatori e fornisce loro una “prima impressione” che si fissa a lungo nella mente e, se negativa, costringe a un notevole sforzo per modificarla.
L’ASPETTO ESTERNO DELLA CANTINA
Le grandi cantine francesi creano un’atmosfera di attesa fin dai cancelli d’ingresso, quelle sudafricane si fanno precedere da giardini fioriti … invece in Italia spesso l’esterno delle cantine è trascurato e in completo contrasto con la cura dell’interno. Io sono fra i detrattori dei pratini all’inglese che sottraggono acqua alla nostra terra sempre più assetata. Così come sono contraria all’eccesso di illuminazione esterna che, di notte, fa sembrare le aziende agricole come alberi di Natale. Un effetto che rovina il paesaggio.
ILLUMINAZIONE E INQUINAMENTO LUMINOSO
Consiglio di puntare sugli alberi e cespugli tipici della zona e limitare l’illuminazione a quella necessaria, ma abbondare in fiori e sedute in modo da far sentire benvenuto il visitatore. Soprattutto bisogna porre tanta attenzione all’ordine, i cestini per le cartacce non sono mai abbastanza. L’illuminazione esterna va fatta con discrezione, ma va fatta. Serve a valorizzare la bellezza del luogo e ad evitare che qualcuno cada facendosi male. Incidenti che comunque avvengono per cui è indispensabile un’assicurazione.
Chi abita in città non è abituato al terreno sconnesso della campagna e inciampa con facilità, inoltre teme i luoghi bui. Per questo è importante illuminare i percorsi e soprattutto le scale.
ARREDO ESTERNO
L’arredo degli esterni ha accresciuto la sua importanza durante il covid quando moltissime cantine allestirono delle aree per degustazioni e pranzi all’aperto. Il vantaggio di assaggiare il vino davanti ai panorami ha poi spinto tante imprese a potenziare il dehors. Terrazze, gazebo, tavoli e sedie, anche per cene nella vigna, sono diventati sempre più diffusi e ricercati da chi viaggia.
È molto importante segnalare i punti panoramici e magari metterci una cornice oppure un’insegna in modo che il visitatore si faccia un selfie e lo posti. E’ un modo per farsi conoscere e creare una catena umana che fa crescere i visitatori. Inoltre fidelizza il visitatore facendolo entrare nella famiglia aziendale.
I PARCHEGGI
Il parcheggio ha un ruolo strategico. Deve essere abbastanza grande per ospitare il numero massimo di visitatori della cantina (anche negli eventi) e consentire ai bus di fare manovre.
Cementificare la campagna è da evitare ma livellare il terreno e coprirlo di ghiaia, in modo che i visitatori non si sporchino nelle pozzanghere, è decisamente opportuno. Con le roventi estati del terzo millennio è prudente pensare a pensiline ombreggianti magari utilizzandole anche per i pannelli fotovoltaici. In alternativa le piante di ampia chioma possono dare ombra e rendere più verde il paesaggio.
La posizione del parcheggio è strategica: è brutto e quindi va allontanato dagli edifici e situato nel punto meno visibile. Ma deve essere anche collegato alla cantina con un breve percorso pedonale e un accesso stradale. In questo modo, il wine lovers sarà invogliato a riempire il bagagliaio con i vini che ama mentre la prospettiva di doverli trasportare a mano potrebbe dissuaderlo.
Il percorso pedonale e il parcheggio devono essere ben illuminati.
E’ abbastanza frequente la richiesta di sosta per camper. Per una sola notte non richiede autorizzazioni che invece sono obbligatorie quando la fermata prende la forma di agricampeggio, con permanenze più lunghe, riguarda più veicoli e offre servizi come acqua, luce e scarico.
LA CERTELLONISTICA INTERNA
E’ utilissimo far sapere ai visitatori tutto quello che l’azienda offre: cantina turistica, ristorante, scuola di cucina, wellness, museo, albergo, piscine, pollaio, caseificio, corso di yoga, negozio di artigianato locale, maneggio …. Questa pubblicità interna serve a guidare il wine lover in cantina ma anche a fargli venire voglia di mangiare, comprare e fare esperienze. Come dice il proverbio <<chi non mostra non vende>> e quindi mostrare i luoghi con insegne sulle porte di ingresso e cartelli ben visibili, nei punti di passaggio, diventa un modo per aumentare il business.
Per evitare l’”inquinamento visivo” dei cartelli è opportuno limitare la loro dimensione e realizzarli in materiali naturali quali legno o pietra. E’ anche importante posizionarli in basso e non davanti al panorama.
Il cartello che ci interessa maggiormente è quello della cantina perché i visitatori trovino facilmente l’ingresso e non vaghino, come succedeva agli esordi dell’enoturismo, cercando di entrare. In questa insegna deve essere indicato l’orario di apertura.
DENTRO LA CANTINA TURISTICA
Questo capitolo è dedicato all’interno della cantina turistica con il percorso della visita guidata, ad esclusione della sala da degustazione e del punto vendita che vengono trattati in altri paragrafi.
Come ben sappiamo la proposta enoturistica italiana si è configurata, fino dall’inizio, come la visita ai luoghi di produzione dei grandi vini e non solo come shopping di bottiglie a somiglianza del modello americano. In questa logica mi sembra giusto soffermarmi sugli ambienti interni della cantina che il turista può vedere.
ENTRARE NELLA CANTINA TURISTICA
Iniziamo con l’annoso problema delle cantine turistiche italiane chiuse nei giorni festivi e nel weekend cioè nei momenti di maggior afflusso di visitatori. Le indagini mostrano un miglioramento ( la domenica il 53% delle cantine sono aperte) ma non la fine del problema.
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Nel migliore dei casi l’apertura festiva avviene previa prenotazione.
La chiusura nei giorni festivi nasce dalla necessità di adibire all’accoglienza turistica personale addetto ad altre funzioni come commerciale, marketing o comunicazione. Dove i flussi di visitatori non sono continuativi, i fatturati non bastano a pagare un intero stipendio e il personale della wine hospitality fa anche altri lavori per cui ha un orario impiegatizio lunedì-venerdì con sosta per pranzo.
Il risparmio di costi, tuttavia, comprime i guadagni. Specialmente nella stagione turistica sarebbe opportuno aprire al pubblico almeno nel pomeriggio. In alternativa bisognerebbe accordarsi su turni di apertura all’interno della stessa denominazione, pubblicizzandoli online.
Una problematica simile riguarda l’orario di pranzo che, all’estero, è quello di maggior afflusso, perché i visitatori consumano spuntini e brunch in cantina o negli spazi esterni intorno ad essa.
In Italia la maggior parte delle cantine chiudono per pranzo. Un grave errore che priva le aziende di introiti aggiuntivi. Infatti la legge permette di servire formaggi, salumi e altri alimenti tipici con cui offrire ai visitatori deliziosi pranzetti accompagnati da grandi vini.
I viaggi enoici sono soprattutto escursioni da mattina a sera nei territori dei grandi vini. Cresce anche il turismo vero e proprio, quello con pernottamento, anche se è minoritario. Si tratta del 37% dei turisti enogastronomici italiani secondo lo studio 2024 di Roberta Garibaldi con ISMEA.
Per questo le città del vino hanno più ristoranti che strutture ricettive e per questo l’apertura delle cantine turistiche all’ora di pranzo e l’offerta di ottimi brunch tipici, potrebbe avere un notevole successo.
INGRESSO NELLA CANTINA TURISTICA
Le prime tre cose chieste dal turista entrando in cantina sono il bagno, la password del WiFi e l’acqua.
Il numero dei servizi igienici dipende dai flussi turistici e dalla necessità di evitare lunghe code e lunghe attese che sottraggono tempo alla visita e allo shopping.
Tenendo presente che ogni donna occupa mediamente un bagno per un minuto e mezzo e un uomo per soli 60 secondi è facile calcolare il numero delle cabine necessarie. Il bagno per disabili è obbligatorio e ovviamente anche quello con armadietti per i dipendenti. I bagni per uso pubblico hanno le stesse norme ovunque: rivestimenti delle pareti, sapone e asciugamani monouso, comando dell’acqua non manuale e contenitore dei rifiuti con coperchio a pedale. Ma bisogna ricordarsi di usare sapone inodore.
La brocca dell’acqua con i bicchieri è sicuramente molto gradita in estate. Una massima saggia dice <<offri l’acqua se vuoi vendere il vino>>. Ma serve anche la ciotola dell’acqua per i cani. Oltre un terzo degli italiani ha un cane e sceglie le destinazioni turistiche dove può portarselo dietro per cui le Wineries dog friendly sono le preferite.
I VANTAGGI DEL WIFI
La connessione internet ha due vantaggi: il visitatore always connected – sempre connesso – è in ansia dove non riceve telefonate e messaggi. Per questo cerca di uscire velocemente. Se il turista ha figli adolescenti questo problema si aggrava. Quindi è vantaggioso dargli una connessione WiFi che lo faccia stare tranquillo.
L’accesso a internet può consentire anche la registrazione del visitatore (attenzione a ottenere il consenso esplicito secondo le norme della privacy) utilissima per il follow up che trasforma il turista in cliente affezionato.
Non tutte le cantine lo fanno ma c’è chi spinge i clienti a saltare la fila davanti al bancone di vendita redigendo online la lista delle bottiglie che vuol comprare. Una tecnica che può essere utile soprattutto con i gruppi ma che richiede una notevole organizzazione nel punto vendita.
ZONA DI BENVENUTO
Generalmente il punto vendita è uno spazio polivalente che serve anche per riunire i turisti prima delle visite guidate e successivamente è il luogo in cui far loro assaggiare i vini. Più raramente la stanza di accoglienza, quella di degustazione e il punto vendita sono separati. Io ho questa logistica nella mia cantina di Montalcino e vedo quanto sia scomoda e richieda un maggior numero di addetti.
La stanza di accoglienza permette di dare informazioni ai visitatori mediante depliant, video o QRcode. E’ il luogo in cui l’azienda si presenta e deve mostrarsi come un luogo unico e diverso da tutti gli altri affascinando il visitatore. E’ importante mostrarsi veri e ricchi di valori, con una storia unica da raccontare e condividere.
Per fidelizzare il turista è utile segnalare un hashtag e chiedergli di usarlo in foto e video da condividere nei social aziendali.
Una raccomandazione: spesso architetti e interior designer creano ambienti bellissimi dove le linee architettoniche impongono un rigore ordinato e scarno all’ambiente. Anche se appaiono splendidi nelle foto, risultano poco coinvolgenti per chi cerca luoghi <<non creati per i turisti>> ma autenticamente collegati alla cultura rurale e alla produzione del vino. Questi turisti sono una percentuale in crescita sia fra chi ha sensibilità ambientaliste sia fra i grandi appassionati che hanno visitato le super tradizionaliste cantine francesi. Per questo bisogna fare attenzione a non creare un luogo adatto solo alle riviste di architettura. Ho visto una cantina del genere in Spagna che, anche per le sue dimensioni enormi, fu ribattezzata la “Hollywood del vino”.
LUCI DELLA CANTINA TURISTICA
Le cantine sono luoghi di lavoro dove c’è un’illuminazione forte che deve agevolare le attività lavorative ed evitare gli infortuni.
La luce per i turisti è invece più soffusa e simile a quella naturale. L’illuminazione può guidare gli occhi verso quello che deve essere visto e mettere in ombra quello che deve essere visto di meno. L’effetto scenografico va limitato per non far sembrare la cantina una cosa finta e destinata ai turisti, ma se ci sono elementi architettonici di pregio, scorci suggestivi, perché non mostrarli?
Ovviamente scalini, cambi di dislivello, rampe e simili vanno ben illuminati perché i turisti, specialmente se anziani, tendono a inciampare facilmente.
Consiglio di applicare il timer o un sensore di movimento alle luci “turistiche” in modo da evitare che rimangano accese dopo il passaggio dei visitatori.
Ribadisco quello che ho già scritto: luci di sicurezza e indicazioni sulle vie di fuga sono obbligatorie per legge. Le interruzioni di corrente sono frequenti in campagna e molte cantine hanno parti sotterranee, quindi quando manca l’elettricità rimangono nel buio assoluto. Per cui, in caso di bisogno, servono strumenti per far uscire i turisti in sicurezza.
ODORI E PULIZIA
Nelle cantine italiane è difficilissimo sentire cattivi odori, comunque è giusto ribadire che non devono esserci, così come non devono esserci profumi. Tutti sanno che i prodotti per la pulizia della cantina non devono contenere cloro (innescherebbe l’inquinamento di TCA Tricloroanisolo che porta nel vino l’odore di tappo, problema comune anche a sbiancanti, antitarlo e alcune vernici) ma anche pulire i pavimenti con prodotti profumati va assolutamente evitato.
La polvere, le ragnatele e le chiazze di umidità sui muri, il disordine e le attrezzature enologiche sporche … dequalificano la cantina anche se in realtà hanno poco a che fare con la qualità del vino. Soprattutto nel mondo anglosassone il concetto di igiene è direttamente collegato al concetto di qualità alimentare. Per questo la cantina deve sembrare pulita e non solo essere pulita, compresi i bagni.
Sul versante opposto gli ambienti asettici di tipo ospedaliero, oppure talmente scenografici da far sospettare che non siano vere cantine di produzione, sono entrambi controproducenti ai fini turistici.
ENOLOGIA E ANTIQUARIATO ENOLOGICO
Le botti e i tini da vinificazione, nelle loro varie tipologie, sono più o meno uguali in tutto il mondo. Agli occhi di un turista che ha già visto molte cantine non costituiscono una seria attrazione anche quando la loro scenografia è suggestiva. Per questo le cantine si popolano di elementi di arredo di vario tipo: dalle opere d’arte contemporanea come a Ca’ del Bosco in Franciacorta, oppure trofei del ciclismo come da Ciacci Piccolomini d’Aragona a Montalcino…. Tali elementi sono utili nella misura in cui si collegano alla storia della cantina e del produttore. Ecco che Paolo Bianchini ha rinunciato a diventare un campione di bicicletta per amore del Brunello mentre Maurizio Zanella è metà wine maker e metà intellettuale.
Io, da signora di campagna toscana, amo conservare i vecchi oggetti della fattoria e questo ingombra la cantina di vecchie pompe, diraspatrici, carri, torchi … Tuttavia, la parte moderna della produzione è ben distinta da quella antiquaria per non far apparire la mia cantina poco aggiornate e attrezzata agli occhi dei visitatori più esperti.
ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI
Accogliere chi ha una disabilità è un segno di civiltà e non solo un modo per rispettare le leggi. La cantina deve essere accessibile, almeno in parte, alle persone su sedia a rotelle e deve avere un bagno per disabili motori. Ma deve essere anche pronta ad accogliere, come un ospite privilegiato, chi non vede oppure non sente. Per i disabili cognitivi, invece, il rapporto con le bevande alcoliche presenta dei seri problemi per cui la visita deve concentrarsi sui vigneti.
I ciechi possono toccare, annusare e assaggiare. Per questo ONAV si è fatta promotrice di degustazioni al buio e della formazione di assaggiatori non vedenti. La visita in cantina va studiata in modo da concentrarla sull’uso di sensi diversi dalla vista, per esempio sugli odori emanati da barrique nuove e dal vino al loro interno. E ancora: la differenza fra i vitigni può essere esemplificata facendo toccare le loro foglie.
I sordi sono generalmente persone socievoli e spiritose. Spesso usano il turismo per coltivare le amicizie e quindi affliggerli con lunghe spiegazioni è inopportuno e bisogna ricordarsi di parlare sempre davanti a loro mostrando le labbra.
ITINERARIO TURISTICO IN CANTINA
L’itinerario in cantina può variare in base al tipo di turisti. Gli esperti potrebbero entusiasmarsi vedendo le parti più innovative della cantina ma per il neofita la reazione potrebbe essere negativa. C’è un crescente sentimento di sospetto verso la tecnologia come se necessariamente comportasse la manipolazione della natura. Per questo, dovendo studiare un itinerario standard, adatto per tutti i visitatori, consiglio di iniziare dalle parti più “calde” della cantina come la bottaia, lasciano per ultime la zona di vinificazione o quella di confezionamento. La prima è un ambiente dove le luci sono soffuse ci sono contenitori di rovere con forme arrotondate che suscitano il ricordo della tradizione del vino. Le emozioni che suscita sono positive e di affezione. La tinaia è invece un ambiente più freddo e generalmente più grande con luci più forti, acciaio, tecnologia, ordine e igiene.
Le soste durante il percorso della visita hanno bisogno di spazio e magari di sedili. Nel mio ultimo viaggio in Champagne, durante la visita alle cantine Louis Roederer, il mio mal di schiena mi ha spinto a sedermi anche sulle scale a pioli.
LO STORYTELLING DELLA CANTINA
Ci sono delle raccomandazioni di base: evitare la terminologia da addetti ai lavori. Pochi sanno quanto è grande un ettaro ma se la guida dice <<più o meno come un campo di calcio>> quasi tutti capiscono. Per cui è bene evitare di fare sfoggio del proprio sapere usando parole difficili. I turisti sono in vacanza, si vogliono rilassare ed annoiarli o farli sentire inadeguati, è l’ultima cosa da fare.
La chiarezza la velocità e l’esemplificazione delle informazioni è la chiave del successo. Invece di dire la data della vendemmia è decisa in base alla maturità fenolica dell’uva è possibile raccontare che quando l’uva comincia a maturare gli enologi percorrono chilometri e chilometri a piedi nelle vigne per assaggiare l’uva e dividere le zone con lo stesso livello di maturazione e qualità. Schiacciando gli acini fra le dita e in bocca riescono a capire se i vinaccioli cioè i semi sono lignificati e se la buccia è pronta. Per poi concludere <<provate anche voi, l’uva è pulita, non usiamo pesticidi qui da noi, potete assaggiarla e indovinare la data esatta della vendemmia>>.
Bisogna parlare poco. Noi italiani siamo noti nel mondo per essere logorroici e gesticolare come marionette. Invece dobbiamo sorridere tanto, avere una gestualità rilassata e misurata e raccontare uno storytelling in grado di emozionare. L’addetta alla wine hospitality deve conoscere a fondo l’azienda, i suoi vini e il suo territorio ma non deve raccontare ai visitatori tutto quello che sa.
Dave scegliere le cose più adatte alle persone che ha davanti. Direi che superare gli 8 minuti di narrazione è pericoloso. I turisti mantengono brevemente l’attenzione e hanno bisogno di muoversi, soprattutto se sono poco esperti di vino. In genere i wine lovers ascoltano più a lungo ma solo se gli argomenti sono nuovi e li incuriosiscono. Chi guida il gruppo deve porre molta attenzione ai segni di insofferenza da parte dei visitatori che ha davanti. Quando li vede annoiati deve farli muovere o cambiare argomento.
Quindi è meglio dividere il racconto “a puntate” e magari dedicare ogni sosta all’argomento più attinente al luogo o agli oggetti intorno. Meglio un aneddoto in più, sullo stesso argomento, che tante informazioni diverse.
Vanno evitati le divagazioni, le frasi al negativo, i concetti astratti, le bugie e soprattutto le maldicenze su altri produttori. Quando non è possibile fare elogi meglio non dire niente. Invece qualche riferimento ai valori su cui si fonda l’azienda serve, soprattutto se ribadito raccontando le ultime iniziative in favore delle comunità locale, delle persone svantaggiate e soprattutto dell’ambiente…. Per esempio, dimenticarsi di dire che la coltivazione della terra e la cantina sono biologici è un grosso errore. Tutte le azioni positive mettono affezione all’interno del vino e creano legami forti fra la cantina e i visitatori che credono negli stessi principi.
In linea di massima i turisti meno appassionati di vino preferiscono gli aneddoti e la storia aziendale mentre i wine lovers gradiscono sapere le novità, le sperimentazioni, le curiosità più direttamente collegati alla viticultura e all’enologia.
Stessa cosa per quanto riguarda i premi e i riconoscimenti. Aver ottenuto 100/100 da Wine Advocate-Robert Parker e non scriverlo a caratteri cubitali … è da sciocchi. Il visitatore sceglie e giudica in base a confronti mentali fra noi le altre cantine o gli altri vini. Tanto vale dirgli di noi, dove siamo superiori a tutti e quello che ci distingue.
Sconsiglio di incentrare la spiegazione solo sul processo produttivo perché potrebbe assomigliare a quella delle altre cantine della stessa denominazione. Se vent’anni fa, quando le cantine turistiche erano poche, una simile spiegazione poteva risultare interessante, oggi rafforza l’opinione dei visitatori italiani che giudicano le cantine “tutte uguali”. Molto meglio puntare sulle differenze senza criticare i produttori che fanno diversamente. Dire male di altre cantine getta un’ombra anche sulla persona che parla mentre l’entusiasmo è un sentimento positivo contagioso.
Quindi le spiegazioni devono alternare dati generali sulla denominazione con specificità e aneddoti aziendali. Bisogna dosare i racconti, essere precisi ma veloci nelle spiegazioni ma anche coinvolgenti ed empatici. La freddezza non crea un legame emotivo con i visitatori e non li spinge a tornare.
E’ ovvio ma desidero ribadirlo: se i turisti posso fare qualcosa di pratico, come pesarsi su un’antica bilancia (la bascula) oppure partecipare alla vendemmia turistica, ne saranno felici. L’esperienza partecipata è sempre un momento emozionante che si fissa a lungo nella memoria. La visita tipo vecchio museo, in cui si ascolta e si guarda, senza fare niente … è proprio venuta a noia.
Ultimissime due raccomandazioni. La visita guidata ha lo scopo di arricchire le conoscenze enologiche del visitatore, fidelizzarlo affettivamente alla cantina e, in tutta franchezza, fargli comprare i vini. Quindi mostrare la bottiglia mentre ascolta uno specifico episodio della sua storia oppure un particolare del suo processo produttivo, potrebbe essere utile. Evitiamo atteggiamenti da “venditore televisivo” ma teniamo a mente che le percentuali di vendita di ogni addetto alla wine hospitality derivano dall’efficacia con cui presenta il portafoglio aziendale. Per ora non c’è l’abitudine di contare gli accessi dei visitatori e gli scontrini di ogni addetto all’accoglienza, come nei negozi, ma presto anche le cantine faranno dei controlli di questo tipo, per cui bisogna partire subito con il metodo giusto.
Ultimissima: la visita guidata va provata più volte, almeno in due lingue, prima della stagione turistica. Questo non significa preparare una sorta di teatrino in cui gli addetti alla wine hospitality recitano un copione. Niente di tutto ciò. Io credo nella forza delle cose vere e l’importanza di essere sé stessi.
Il mio consiglio mira ad essere ben preparati sui contenuti in modo da esporli con scioltezza senza concentrarsi per ricordare le informazioni ma invece dedicando il massimo sforzo all’espressività: il linguaggio del corpo, il tono di voce, le pause, il movimento degli occhi che controlla l’attenzione dei turisti e instaura con loro un legame emotivo. La cosa più memorizzabile sono le emozioni e non le informazioni. Per questo, la stessa cosa espressa in due modi diversi produce due effetti diversi.
LA TIPOLOGIA E LA DURATA DELLA VISITA TURISTICA
Il 95% delle cantine italiane propone la visita guidata agli impianti produttivi (cantina e vigneti) con assaggio finale. A questa si aggiungono altre esperienze progettate in base al target dei visitatori (gruppi, individuali wine lovers, famiglie …) oppure alle specificità dell’azienda.
Un portafoglio di proposte che non dovrebbe superare le 4 esperienze diverse più una proposta premium con caratteri di eccezionalità e alto prezzo. Hanno questo tipo di portafoglio il 65% delle cantine del Movimento Turismo del Vino.
Ritengo invece sbagliato eccedere offrendo un ventaglio enorme di scelte perché la legge del marketing chiamata il “paradosso delle scelta” ci dice che l’eccesso di opzioni scoraggia i clienti.
Mezz’ora, quaranta minuti per il winery tour e circa lo stesso tempo per la degustazione. E’ possibile superare questi tempi con attività coinvolgenti e più articolate quali, ad esempio, gli assaggi verticali che iniziano dal barrel tasting in bottaia e proseguono fino alle grandi riserve. Oppure mostrando la differenza di percezione derivante dall’assaggiare lo stesso vino in bicchieri diversi o con accompagnamento di musiche differenti.
ACCESSO LIBERO O SU PRENOTAZIONE
Sempre più spesso le cantine turistiche organizzano le visite in base a un calendario e a orari fissi. E’ un sistema che riduce i costi di manodopera ma omologa la proposta su quella standard più semplice. Una certa flessibilità è sempre necessaria specialmente nelle aree dove i flussi enoturistici non sono ancora molto forti e dove l’obbiettivo è ridurre i numeri e innalzare il target.
Va ricordato infatti che mentre l’”enoturista per caso” accetta volentieri una visita in gruppo, l’appassionato di vino e soprattutto il visitatore esperto, preferisce una visita più personalizzata e sono proprio questi ultimi clienti quelli che, generalmente, comprano bottiglie più care e in maggiore quantità.
L’accesso su prenotazione è cresciuto nel periodo del Covid e poi è rimasto come pratica “mista” sia in USA (4), dove il 43% delle cantine la pratica (solo il 29% riceve esclusivamente su prenotazione), che in Italia dove la percentuale sale fino al 68%. Le cantine accessibili solo su appuntamento sono quindi minoritarie ma, spesso, sono le più prestigiose.
Il turismo del vino ha una stagione molto lunga a somiglianza del turismo d’arte. In inverno i flussi cessano quasi del tutto anche se la stragrande maggioranza delle cantine turistiche rimane comunque accessibile. I visitatori ricominciano ad arrivare ad aprile e continuano ad affluire fino a novembre. Recentemente l’autunno è il periodo in cui entrano in cantina la maggior parte dei wine lovers anche attratti dall’epoca della vendemmia e dalla possibilità di prendervi parte. Agosto è invece il mese di vacanza in cui la qualità dei visitatori si abbassa e il numero degli accessi cresce.
PREZZI DELLE ESPERIENZE
I prezzi delle esperienze stanno crescendo in tutto il mondo e quindi anche nelle cantine turistiche italiane. In linea di massima partono da 15€ a persona ma le proposte standard si aggirano sui 25€ mentre salgono intorno ai 50€ per quelle più strutturate. In questa fascia di prezzo si collocano anche la maggioranza delle offerte premium benché alcune cantine propongano anche qualcosa di più esclusivo intorno ai 150€.